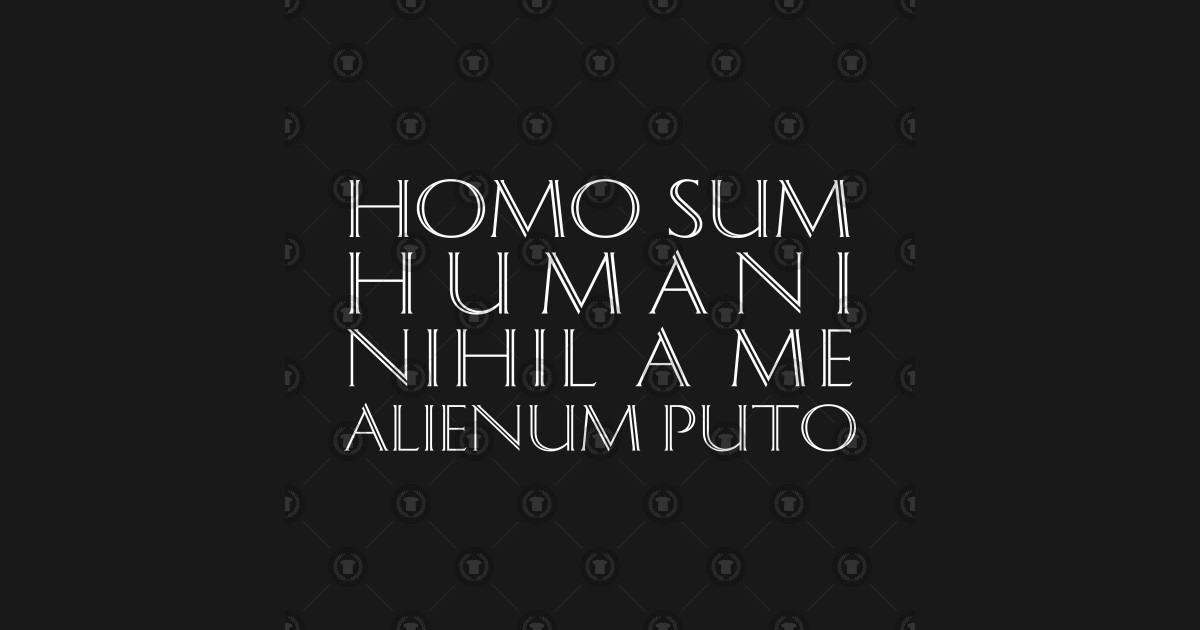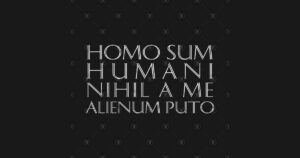
CAPITOLO IV
La “scienza” propagandata dai media
La questione riguardante l’informazione in Italia rispetto alla pandemia, il complesso della mediaticità della vicenda, e i rapporti di questa con il potere politico, è – come si è cercato di spiegare – un argomento a sé, ben diverso dalla vera e propria concreta diffusione planetaria di un nuovo virus aggressivo per l’uomo. Il racconto mediatico della pandemia ha investito miliardi di persone, pressoché l’intera umanità, mentre il virus in sé ha raggiunto al confronto una sparuta minoranza. È impossibile per noi stabilire se il racconto mediatico della pandemia in Italia è stato il migliore possibile ai fini di ridurre al minimo i danni complessivi indotti dalla pandemia stessa. Ci limitiamo a indicare questo quesito, sottolinenado con forza qualcosa di concettualmente ovvio ma forse poco avvertito a livello generale: non esiste un modo solo, obbligato e “giusto” di trattare mediaticamente un argomento così intensamente sentito da ciascuna persona che costituisce il pubblico, si possono seguire linee molto differenti l’una dall’altra, ciascuna verosimilmente con vantaggi e difetti. Il sensazionalismo ha il merito di attirare molto l’attenzione, sia per la paura che diffonde che per le reazioni psicologiche che abbiamo descritto. Ma ha diviso gli italiani, accendendo rancori civili, con la sollecitazione di odi tra categorie (ad es. dipendenti pubblici vs. privati), e ha ammiccato in favore di abnormi tratti psicologici della popolazione. Una trattazione più sobria, circoscritta alla comunicazione ordinata di istruzioni pragmatiche avrebbe certamente eccitato meno le menti e i cuori, ma non avrebbe raggiunto gli elevatissimi livelli di attenzione pubblica ottenuti in Italia. Lo stile mediatico italiano è appunto uno stile, non è necessariamente quello “giusto”. Si devono quindi tirare le somme per giudicare se è stato il migliore stile ai fini pandemici. I media italiani hanno adottato la migliore strategia possibile di informazione ai fini della riduzione del danno? Il governo ha comunicato nel modo migliore?
Troppo forte è il sospetto che i media non abbiano perseguito come solo obiettivo la maggiore salvaguardia possibile della popolazione. Il primo elemento a stonare fu la ostentazione della “guerra” tra virologi. È consuetudine vedere in TV esperti consultati sulla loro materia. L’esperto normalmente è chiamato a esprimere un parere specialistico (sia esso scientifico, tecnologico, politico, ecc.) su questioni che non hanno un collegamento diretto con la vita fisica quotidiana dei milioni di individui che lo ascoltano. L’esperto esprime una consulenza che in genere costituisce – per la maggioranza degli spettatori – non più di un contributo culturale al dibattito in corso. Un esperto meteorologo apporterà la sua visione sulla origine del riscaldamento gobale, che tocca sì genericamente tutti, ma non se ne ha la sensazione che possa uccidere ciascuno domani. Un esperto politologo ci spiegherà qual è per lui il miglior sistema elettorale, e noi, ammesso che capiamo di cosa egli parli, apprendiamo con distacco qualcuna delle sue idee. L’esperto in TV è paragonabile a un relatore a un congresso scientifico: questi aggiunge semplicemente la sua voce a un dibattito culturale.
L’impatto della consulenza dell’esperto cambia radicalmente se il contesto è diverso dalla “normalità” e quindi se la sua risposta può essere interpretata come una indicazione vitale, di grande dirimente importanza: se sono gravemente ammalato e consulto uno specialista della mia malattia, tendo a pendere dalle sue labbra. La mia vita, tutto me stesso, i miei orizzonti, la percezione di me e del mondo, potrebbero dipendere dal parere di quel medico: “non hai scampo”, oppure “possiamo risolvere il problema”, non restano solo frasi che culturalmente contribuiscono al dibattito scientifico generale su quella brutta malattia, diventano sentenze sulla mia singola, personale vita. Chiamare un astronomo in TV a parlare di asteroidi in condizioni normali è ben diverso dal sentire cosa ha da dire mentre tutta l’umanità sa che un asteroide sta per colpirla. Il dibattito virologico iniziò in Italia con le caratteristiche del normale, scontato consulto dell’esperto. In una rete si vedeva Burioni, nell’altra Galli, in un’altra Bassetti. Niente di strano. Solo che l’argomento, includendo il rischio di vita e lo stravolgimento della stessa per milioni di persone, non poteva mantenere in sé una valenza soltanto scientifica, da dibattito congressuale. La scienza è costituita nel suo insieme da un incessante dibattito culturale che è tale, e gode dell’essere tale, proprio perché non si relaziona direttamente a impellenti necessità vitali. La scienza è di fatto costituita da pubblicazioni che si accumulano combattendosi, smentendosi a vicenda e contro-smentendosi, il suo pane quotidiano sono le polemiche, le contraddizioni, gli affondi in avanti e i ripensamenti all’indietro, in tutto simili ai pareri che abbiamo visto per mesi esprimere in TV dai tanti virologi. È del tutto normale per la scienza un dibattito fatto di posizioni diverse, spesso contrastanti. Ma se il contesto all’interno del quale si chiede il parere dell’esperto non è più un elegante congresso di infettivologia con pranzo in terrazza sul mare, se non è una trasmissione di seconda serata dedicata alla ecologia marina dei coralli, e invece il contesto diventa quello della visita clinica del medico luminare sul paziente a grave rischio della vita, il peso specifico psicologico della consulenza cambia radicalmente.
Il pubblico italiano inizialmente è chiuso in casa per il lockdown ed è massimamente attento a ciò che i virologi dicono, sia per l’estrema novità/intensità mediatica della vicenda, sia perché vi vuole trovare delle informazioni davvero utili per sé, per la sua vita, per le proprie condotte quotidiane. Quando l’infezione è ancora un fatto solo cinese alcuni esperti affermano in TV che si tratta di una malattia non rischiosa per l’Italia; c’è chi la giudica solo una forte influenza, c’è chi è allarmista sin dall’inizio. L’attenzione su questi pareri da parte del pubblico è alta, per via della situazione generale. Con il passare delle settimane la presenza mediatica degli esperti si intensifica e si allunga a dismisura, e i pareri si sommano e si diversificano sempre più, includendo quelli che appaiono dei clamorosi dietrofront: la mascherina che andava messa solo dinanzi al malato conclamato, poco dopo è indispensabile in qualunque circostanza di incontro fisico con altri; chi diceva che il rischio era infimo diviene allarmista; se dapprima il lavare le mani è la suprema regola, poi si dirà che il contagio da recuperi del virus su oggetti è irrisorio. Il professore Montagnier, nobel per l’isolamento del virus dell’HIV, da anni inviso per le sue presunte eccentricità anti-scientifiche alla comunità scientifica “ufficiale”, afferma candidamente che il virus portebbe essere un prodotto artificiale da laboratorio, e sugli stessi grandi network che gli danno voce egli viene ridicolizzato da suoi colleghi molto meno noti. Ovvero, nel complesso si svolge in TV, di fronte a milioni di persone condizionate dalla pandemia, un normale dibattito tra scienziati, con chi la dice cruda e chi cotta, chi appartiene a una data scuola di pensiero e chi invece la combatte. Avviene ciò che succede giornalmente, normalmente, nel dibattito scientifico. Il problema è che non siamo a un congresso, non siamo a una conferenza riservata a studiosi: siamo in TV dinanzi a milioni e milioni di persone terrorizzate, eccitate, insospettite, avvilite, esaltate e soprattuto raggiunte dal virus: molti hanno già perso propri cari nel modo più atroce, privati del contatto finale con essi e delle esequie, per via dei divieti imposti dai dpcm del presidente Conte.
Gli esperti si esprimono in TV per come sanno, da scienziati. Le redazioni li chiamano come esponenti della scienza. Ecco che si sta per compiere una grave mistificazione di massa, forse sul piano culturale la più dannosa di tutto il periodo: il contrabbando del concetto di scienza. Virologi, igienisti ed epidemiologi conquistano rapidamente – e spesso loro malgrado – lo status di stelle della TV. Questa non sarebbe una questione di specifico interesse se non fosse il nucleo comunicativo di una campagna mediatica gravemente distorcente il concetto di scienza. Le apparizioni degli esperti si allungano per mesi, riguardano quattro/cinque titolati che via via si trasformano di fatto agli occhi del pubblico in personaggi. Assistiamo in estate a uno scontro a distanza tra quello che ormai incarna, per via delle tante settimane di mediaticizzazione del dibattito, il virologo di “Destra” (Zangrillo), con posizioni anti-allarme, che si trascina dietro le masse antigovernative, e il virologo di “Sinistra” (Galli), che con il suo carisma fatto di sprezzante snobismo delle voglie estive popolari e vitalistiche di balli, viaggi e bagordi incarna bene il ruolo del moralizzatore inascoltato ma preveggente (“ve lo avevo detto, io!”), e piace agli ossessivo-fobici, al governo e alle masse che questo sostengono. I due professori sono ormai dei personaggi televisivi che per il pubblico hanno più peso propangandistico elettoral-politico che virologico. L’eccezionalità della situazione pandemica ha fatto sì che gli esperti del virus siano rimasti in TV per molti mesi, seguiti da milioni di persone con un’attenzione palesemente straordinaria. Le redazioni sono forse davvero convinte che la loro costante, lunghissima consultazione possa apportare utilità concreta contro il virus, ma è certo che sono anche consapevoli del grande successo di ascolti che queste nuove e impreviste star mediatiche contribuiscono a ottenere. Ovvero si mescolano per molti mesi elementi in origine distinti: i contenuti scientifico-virologici veri e propri, che per loro stessa natura sono in continua variazione e spesso si contraddicono da un giorno all’altro, e le regole e gli obiettivi tipici della grande comunicazione di massa, cioè il successo di pubblico, l’audience. Non è detto che quest’ultimo sia cercato spregiudicatamente a scapito della più ragionata trattazione dei primi; noi crediamo nella buona fede di produttori e autori televisivi convinti di apportare con la presenza costante dei “virologi” un contributo davvero utile al contrasto della pandemia: la buona fede però, in tal caso, sarebbe frutto di una conoscenza carente dei meccanismi e delle regole della comunicazione, laddove un contenuto trasmesso come messaggio cambia totalmente il proprio significato a secondo del contesto che lo circonda e caratterizza. Dire, da parte del professore, a un gruppo di studenti a lezione di infettivologia “forse la clorochina può dare qualche risultato, attendiamo nuovi studi” è ben diverso dal dirlo ai familiari di un malato di covid che sta palesemente peggiorando. Il malato, i suoi familiari, per quelli che sono i loro bisogni impellenti, si aspettano delle indicazioni definite e il più possibile incontrovertibili, non possono tollerare dal medico dalle cui labbra pendono indicazioni vaghe e continuamente mutanti. Non possono, in altre parole, sentirsi rispondere alle accorate domande riguardanti la vita o la morte, la salute o la disabilità, con un pezzo di dibattito scientifico preso da riviste specializzate. La scienza, infatti, non coincide affatto in toto con la medicina. Nessuno si cura consultando gli articoli di “Science, “Nature” o il prestigiosissimo “New England Journal of Medicine”. Il medico che ha di fronte il malato esercita su di lui un condizionamento psico-relazionale che non si esaurisce affatto con un elenco di citazioni di articoli scientifici, che magari stanno tra loro in una normale, dialettica contraddizione. Gli esperti della TV, dopo molte settimane di notorietà dovuta alla straordinaria attenzione catalizzata su di essi dalla eccezionale condizione della pandemia globale, diventano in realtà per il pubblico delle figure ambigue, perché ambiguo è il ruolo comunicativo che essi si trovano a intepretare in un contesto in cui vengono mescolate scienza, succeso mediatico, politica, medicina vera e propria. Maliziosamente oppure ingenuamente i conduttori dei talk show continuano a presentare i “virologi” come rappresentanti della scienza, ma chiedono loro delle risposte pratiche, certe, univoche, ovvero pretendono delle indicazioni mediche, quando non anche politiche. La scienza fa dibattiti, discute genericamente in assenza di impellenze pratiche. La medicina è obbligata a dare risposte quanto più definite perché si confronta con la sofferenza, il dolore, le aspettative, le speranze del malato. Il pubblico in piena pandemia somiglia più al malato che non allo studente di medicina a lezione, o all’appassionato per proprio interesse culturale agli agenti infettivi. I vari Galli, Pregliasco, Bassetti, ormai incastrati nel ruolo di personaggi televisivi – volenti o nolenti – rispondono per come sanno, da veri scienziati: e quindi nel giro di settimane cambiano spesso parere, sono vaghi, citano dati poco affidabili, si sperticano in pure ipotesi, ovvero riportano in TV il dibattito scientifico per come esso si sta sviluppando sulle riviste specializzate intorno al tema covid, peraltro nuovissimo e sconosciuto. Il pubblico, che non aveva mai visto prima un virologo in vita sua, e forse non sapeva cosa fosse, è concentratissimo per mesi sulle parole dei virologi, e quindi nota le contraddizioni via via evidenti del loro dire, si accorge che le loro risposte sono vaghe, si scandalizza per la disomogeneità dei pareri di questi, che pure sono tutti esponenti della stessa scienza. Il pubblico si stupisce del fatto che la scienza non sia univoca e omogenea, che non dia certezze definitve, che si contraddica di giorno in giorno, che non ne azzecchi una. Ovvero si stupisce della più tipica natura del dibattito scientifico, della scienza. E lo fa perché il contesto mediatico-pandemico fa assumere al pubblico lo stesso ruolo che è del malato dinanzi al medico: è attentissimo, perché si parla della sua vita, e non tollera che gli si risponda con citazioni di riviste e ipotesi vaghe.
I media premono l’acceleratore su questo equivoco, chiamano scienza quelle risposte che dagli scienziati non possono arrivare e che dovrebbero invece somigliare a delle indicaziomi mediche, delle vere e proprie prescrizioni fatte dal clinico al malato: “prenda queste pillole a tali orari, si astenga dal fare questo e quest’altro, faccia tali esami, ecc.” Il medico fa delle scelte che prescrive al malato empiricamente, prendendosi la responsabilità professionale di far cadere queste prescrizioni addosso al paziente dall’alto del suo ruolo professionale. Ma questo non coincide con la pedissequa applicazione di una “verità” scientifica. I giornalisti mettono in realtà in croce gli esperti chiedendo loro certezze e chiamando queste certezze “scienza”. La gente si convince, pertanto, che la scienza dia certezze. L’inevitabile mancanza di certezze, anzi il contributo all’incremento dell’incertezza che gli scienziati in TV producono nel pubblico, mentre questo li vede come medici cui affidare la propria vita, svilisce agli occhi del pubblico il concetto di scienza. La scienza di Galli, di Pregliasco, di Bassetti è farlocca perché non dà certezze: all’inizio si escludeva che il virus fosse da laboratorio, poi questa è diventata un’ipotesi molto probabile; all’inizio il virus si propagava a decine di metri di distanza tra una persona e l’altra, poi ciò è stato ridimensionato; prima colpiva solo gli anziani defedati, poi anche giovani in forma; le discoteche sono colpevoli dei rialzi settembrini, no, è la scuola. Siccome si è fatto credere al pubblico che la scienza debba dare certezze definitive (la scienza invece è per sua natura dialettica), il pubblico che rileva attentissimo valanghe di contraddizioni perde fiducia nella scienza.
Agitare come un vessillo nobile in TV la scienza per persuadere il pubblico si rivela la più micidiale arma di affossamento di fiducia nella scienza.