Luca Nicotra
PUBBLICAZIONE N 1
INTRODUZIONE
Le informazioni riguardanti la pandemia, la stessa esistenza di essa, sono giunte nei mesi della sua esplosione a ciascun individuo (o quasi) nel mondo tramite i mezzi di informazione di massa. Nel mondo contemporaneo questo è ovvio, del tutto normale: un fenomeno che abbia una certa rilevanza x diviene noto a un numero di persone ultra-elevato rispetto al numero di individui che sono toccati, colpiti davvero dalla natura originaria del fenomeno stesso. Un attentato terroristico colpisce nella carne e nella vita un numero circoscritto di persone fisiche che si trovano in un dato luogo in un dato tempo, le vere e proprie vittime di quell’atto criminale di violenza, che sul piano penale sarà strage, omicidio, aggressione, ecc. È il meccanismo dell’informazione mediatica che estende a uno sconfinato pubblico, a un numero di persone immensamente superiore a quelle fisicamente colpite – uccise o ferite – una parte del carattere violento, aggressivo, di un atto che nella sua quota fisica è circoscritto. Quell’atto criminale include una natura di messaggio, per precisa intenzione. I terroristi sono tali proprio perché tramite la risonanza che ingenerano le loro atrocità mediante i canali dell’informazione veicolano un messaggio appunto di terrore, che travalica lo specifico atto violento fisicamente diretto contro alcuni, in un luogo preciso, in un dato momento, e raggiunge in qualità di minaccia un numero enormemente superiore di persone. Un terrorista si distingue da un “semplice” assassino proprio per questo: perché utilizza l’informazione di massa per minacciare un numero esponenzialmente superiore di persone rispetto a quelle che uccide. Teoricamente non potrebbe esistere il fenomeno specifico terroristico se non esistesse la “comunicazione” pubblica, l’informazione.
È una questione ormai antica, ben nota e dibattuta, quella delle potenzialità nocive, degli “effetti collaterali”, che possono prendere corpo e venire enormemente diffusi tramite un’attività considerata nel complesso essenziale per il funzionamento della democrazia e dello stesso contratto sociale: il diritto di cronaca. Molti si chiedono se è opportuno, se è davvero utile, ad esempio, dare per l’ennesima volta notizia in TV di un ulteriore femminicidio, o di qualche altra atroce brutalità non nuova nella sua essenza alla cronaca ma reiterata a tempo indeterminato in singoli episodi. Alcuni decenni or sono si verificò in Italia un’ondata di suicidi di giovani mediante aspirazione di monossido di carbonio dai gas di scarico delle automobili che parve essere alimentata per emulazione dalla stessa informazione sui singoli episodi. Un dilemma relativo alla necessità di raccontare la realtà dei fatti da un lato (la cronaca), e la remora che tale racconto possa ingenerare altro male è vivo ogni giorno ed è un argomento ormai antico. Possiamo sintetizzare questo problema con l’espressione “potenzialità negative e/o emulative del male tipiche dei mass media”. Non è affatto questo– lo anticipiamo – il tema di questo nostro saggio: l’ambiguità pericolosa del potere mediatico, lo ribadiamo, non è certo stata inaugurata dalla pandemia di covid. Sono altre e a nostro avviso nuove le implicazioni problematiche che l’incontro covid/comunicazione globale ha ingenerato. Ma è opportuno qui ribadire quale sia la potenza sociale dei media, con la loro capacità di veicolare messaggi a livello globale, perché è comunque da questo potere, dalla semplice e antica “potenza di fuoco” dei mezzi di comunicazione di massa che parte l’evento pandemia per come a noi interessa qui: una notizia strepitosamente eccezionale comunicata per molti mesi dai media al pubblico del mondo, e il fatidico intreccio, nello specifico in Italia, di questo livello mediatico tout court con quello prettamente sanitario/politico, includente la necessità del governo di diffondere nella popolazione la conoscenza e l’adesione alle misure restrittive anti-covid disposte. Il nostro lavoro ha per oggetto di interesse primario, pertanto, quella che ci appare come una miscela inedita e ambigua di messaggi comunicativi, composta da due elementi: 1) la ininterrotta puntigliosa trattazione da parte dei media della pandemia in ogni suo aspetto clinico, epidemiologico, immunologico, virologico, politico, economico, ecc.; 2) l’urgenza del governo di comunicare alla popolazione istruzioni operative anticovid.
Questi due filoni comunicativi hanno nature profondamente diverse tra loro. La nostra tesi, che vuole essere dimostrata dal presente lavoro, è che la confusione tra queste due linee profondamente eterogenee di “messaggio”, di informazione inviata verso uno sconfinato pubblico, abbia ingenerato dei notevoli danni di vario genere, che cercheremo di descrivere, ma soprattutto abbia gravemente complicato il raggiungimento dello scopo dichiarato dei messaggi stessi, il contrasto della pandemia, costituendone invece, complessivamente, un enorme ostacolo.
PARTE I
Prime notizie in Italia
In Italia l’attenzione si accese a fine febbraio del 2020. Le notizie di malattia vera e propria riguardavano una gigantesca città cinese totalmente sconosciuta ai più degli italiani: Wuhan. In quel momento il rischio per il resto del mondo non era dai media granché contemplato: l’italiano medio incamerava queste informazioni, sulle quali era concentrato poco e vagamente, come la solita notizia di un evento malefico distante, che tocca altri. La lontananza remota della cosa veniva amplificata dalle subentranti informazioni riguardanti l’origine dell’infezione umana, che sarebbe stata favorita dalle caratteristiche primitive di alcune tradizioni alimentari cinesi: nel poi famoso mercatino di Wuhan – apprendemmo – venivano macellati in loco animali selvatici, che in Cina sarebbero prelibatezze alimentari. Il celeberrimo pipistrello avrebbe trovato il modo di infettare qualcuno di questi poveri animali della foresta che quei “selvaggi” degli avventori del mercatino di Wuhan si sono poi mangiati; o qualche sanguinario macellaio del mercato si è contaminato mediante un contatto sangue/sangue. O addirittura qualcuno mangia proprio i pipistrelli… Non fu chiarissimo. Venimmo improvvisamente a conoscere la parola (e l’animale) “pangolino”.
Il salto di specie consiste in un passaggio dal pipistrello delle foreste a essere umano cinese che, visto dall’italiano che ascolta i media, incomincia quindi ad assumere le caratteristiche di un selvaggio. La primissima ondata di pareri qualificati, di virologi ed esperti del settore, rinforzò la sensazione di distanza, di remota differenza tra due società: il prof. Burioni stesso, già noto alle cronache per le sue polemiche con i “no-vax” italiani pre-covid, affermò che il rischio che il virus raggiungesse sotto forma di grave malattia l’Italia era remoto. Eppure nel frattempo i media si interessano sempre più all’epidemia.
In questa fase, dunque, la più netta connotazione che i media italiani danno alla vicenda è l’estrema lontananza, una distanza che non è solo geografica ma anche culturale e sociale; e non ancora politica, aspetto che entrerà in scena poco dopo. I cinesi di Wuhan vengono raccontati, inevitabilmente, come dei primitivi, che a causa delle loro retrograde abitudini igieniche vengono colpiti maleficamente dalla natura. Quasi una punizione questa, vista da quella parte di mondo, l’Occidente, che rappresenta l’apice del progresso sociale e igienico – almeno questo esso crede di se stesso – e che da pochissimo è stato investito dal fenomeno mediatico Greta Thunberg, con i suoi anatemi ecologisti e animalisti. Queste gravi polmoniti che stanno ammazzando molti abitanti di questa sconosciuta e quasi aliena megalopoli cinese, Wuhan, sono l’effetto dell’inciviltà dei cinesi. Sintetizziamo di seguito volgarmente un’idea che potrebbe aver preso corpo, più o meno consciamente, nella testa di molti italiani dinanzi a quelle notizie: “’sti cinesi saranno organizzati, saranno pure diventati ricchi e potenti, ma sono pur sempre dei selvaggi che si mangiano i pangolini e i pipistrelli!”
È un’ottima occasione per riversare sulla Cina il rancore di chi è stato surclassato da tempo: questo gigante, questa superpotenza in espansione estrema, questa centrale immensa che invia in diaspora pre-organizzata milioni e milioni di suoi figli a comprarsi a pezzi e in contanti il resto del mondo, finalmente arranca. E arranca perché è primitiva e incivile nel profondo, nelle stesse condotte di vita quotidiane e igieniche del suo popolo. In questa prima fase di conoscenza mediatica la malattia è una pericolosa forma spuntata in un pianeta lontano, la Cina, per colpa della scarsa igiene degli alieni che lo popolano, i cinesi.
Si registrano degli incresciosi episodi di additamento e rancore nei confronti di cinesi presenti in Italia. Si parla di razzismo. Si deve però far notare che all’interno del lungo precedente dibattito pubblico italiano, basato sulla contrapposizione tra forze politiche favorenti l’immigrazione poco controllata e altre decisamente contrarie, è stato sbandierato moltissimo il tema del razzismo: ma mai questo aveva lambito i cinesi. Ben presenti in Italia da decenni, questi non erano mai stati protagonisti di vicende ed episodi di cronaca allarmanti, a differenza di altre etnie, sulle quali si era molto concentrata l’attenzione mediatica; in particolare quelle africane, protagoniste degli sbarchi immigratori clandestini contemporanei. I cinesi hanno sempre fatto vita apparentemente tranquilla e del tutto separata, parallela a quella dei cittadini italiani, rimandando ad essi un’immagine di operosità ostinata e silenziosa, quasi misteriosa e di ispirazione formichesca. Non c’è traccia di razzismo nei confronti di cinesi nei moltissimi anni di convivenza con gli italiani. Ma ora esplode un altro sentimento, non il razzismo: il rancore. Già da molti anni i cinesi si erano notevolmente arricchiti mentre gli italiani arrancavano sempre più, in particolare dopo la crisi economica del 2008/2010. Gli episodi di aggressività del 2020 contro persone cinesi sono mossi da rancore nei confronti di chi viene percepito arricchirsi a scapito degli italiani e che, in più, è un incivile che macella al mercato animali selvatici, se li mangia e per questo fa scoppiare epidemie. Un ospite invadente e pericoloso.
L’attrazione media/pubblico è quindi in questa primissima fase caratterizzata dall’accensione di attenzione nei confronti di un mondo alieno pericoloso, e pericoloso perché in fortissima espansione economica ma basato su differenti principi di civiltà.
Specifichiamo che questa nostra non è affatto, e non vuole esserlo, una ricostruzione storica puntuale di ciò che realmente avvenne; non è neanche una ricostruzione ordinata delle vere e proprie cronache del tempo: il nostro interesse è volto verso il modo di percezione delle notizie da parte del pubblico, l’effetto psicologico complessivo, si potrebbe dire collettivo, che quelle notizie hanno prodotto. È questo l’oggetto del nostro interesse: il legame psicologico tra media e pubblico in occasione della pandemia di covid-19.
Il lockdown a Wuhan
Lo scenario cinese comunicato dai media si aggrava rapidamente. L’epidemia a Wuhan è fuori controllo: si diffondono immagini nelle quali si vedono cadaveri per strada e passanti in mascherina che ignorano questi corpi. Cominciano ad arrivare notizie riguardanti le misure contenitive imposte dal governo cinese: il lockdown ferreo con controlli imponenti e puntigliosi del territorio e sanzioni inimmaginabili per uno Stato occidentale.
Ecco che irrompe marcatamente sulla scena, anche per lo spettatore medio, non particolarmente istruito sulle caratteristiche politiche e la storia rivoluzionaria cinese, la Cina come ente politico, come Stato. La prontezza ed efficienza spiccia del governo cinese – questa ne è la narrazione/percezione – sono sì aliene al cittadino italiano, ma iniziano ad assumere l’aspetto di caratteristiche desiderabili. Il governo dittatoriale cinese incarna esattamente l’antitesi dell’idea di governo diffusa in Italia. Ci si accorge che un governo può immediatamente imporre delle regole ai suoi cittadini, regole che non sono astratte, generiche, teoriche, valevoli in specifici casi di giurisprudenza, no: il governo cinese impedisce al singolo di compiere molte delle sue azioni quotidiane semplici, azioni che normalmente sono lontanissime dall’essere considerate di interesse governativo. Almeno in Italia. Il singolo individuo a Whuan è raggiunto personalmente, nel suo stesso corpo, e viene obbligato a non spostarsi fisicamente oltre un certo perimetro di spazio, gli è intimato di attenersi a precise indicazioni di tempo: deve stare chiuso in casa, non può circolare oltre un certo orario (coprifuoco), deve compiere in situazioni predefinite specifiche azioni igieniche sul suo stesso corpo (mascherina, disinfezione mani, misurazione della temperatura in accesso a uffici, enti, supermercati ecc. ). Queste imposizioni in Cina non sono leggi contro le quali, una volta fatte, si trova l’inganno: no. In Cina i controlli sono a tappeto, le punizioni rapide e pesantissime. Il governo c’è, il governo può, il governo fa.
Dentro la mente dello spettatore italiano forse scorre confusamente un fiume di parole note foneticamente ma dal significato impreciso: “Parlamento”, “ministro”, “governo”, “Presidente del Consiglio”, “decreto”. La maggioranza degli italiani non sanno definire queste istituzioni, non sanno cosa siano esattamente. Se chiedessimo ai passanti per strada di definire “Presidente del Consiglio” o “Parlamento” otterremmo risposte compiute e corrette nella minoranza dei casi. Ciò è certamente attribuibile in buona parte a una certa fisiologica ignoranza: il cittadino medio non ha studiato con sufficiente definitezza questi argomenti, né ha interesse personale specifico a farlo. E ciò è così, si badi bene, nonostante egli sia ogni giorno investito da una mole consistente di notizie che nominano esplicitamente queste istituzioni, o vi fanno ovvio riferimento. Pensiamo alle cronache politiche dei TG, ai talk shows, alle polemiche politiche sui social. Lo spettatore italiano medio probabilmente sa qualcosa del leader di un partito, ha magari preso posizione dentro di sé rispetto a questo o quell’altro esponente politico che si vede in TV, ma non sa invece cosa fa esattamente il Parlamento, o come esso è diviso; non sa indicare con precisione la differenza tra Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica; è piuttosto raro che sappia qual è la differenza tra una legge ordinaria e un decreto del governo. Possiamo dire, con una metafora, che conosce alcuni giocatori ma non ha molta idea di quale sia il gioco in cui essi sono impegnati. Ma improvvisamente arriva dalla aliena Cina una forte delucidazione: un governo può, un governo fa, un governo punisce.
Il deficit istruttivo del cittadino medio italiano non spiega da solo l’ignoranza che egli dimostra delle istituzioni. Le conosce male, in modo indefinito, come qualcuno o qualcosa di cui ogni tanto sentiamo parlare mentre siamo distratti, anche proprio perché esse, le dette istituzioni, non hanno in realtà in Italia frequenti occasioni per palesarsi al singolo cittadino. Ciò è piuttosto tipico delle nazioni liberali, improntate su base democratica a un principio di grande possibilità di indipendenza personale, autonomia, margine di azione individuale del singolo. In ambiente di democrazia liberale è normale, è una condizione scelta che il governo non si palesi costantemente al singolo in una qualche forma: controlli pedissequi dei domicili da parte della polizia, esattori delle tasse che siano autorizzati a venire a casa senza preavviso, la schedatura obbligatoria completa delle caratteristiche medico/infettive, sono esempi di cose che in regimi liberi non si fanno per precisa scelta. Sono le dittature che si palesano costantemente ai propri sudditi, che li controllano, li orientano di continuo, li indottrinano: è proprio tramite un frequente e costante palesarsi ai sudditi che la dittatura esercita il suo potere tirannico, che compie la sua natura. Pensiamo ai culti della personalità del dittatore: Hitler, Stalin, Mussolini, venivano continuamente narrati al popolo e questo lo manteneva in costante subordinazione rispetto al dittatore. Il suddito di una dittatura è obbligato a sapere bene cosa è un governo, anche se non lo ha studiato. Come un soldato analfabeta che combatte al fronte sa bene cos’è la guerra.
L’italiano scopre all’improvviso, tramite ciò che egli apprende da Wuhan in termini di imposizioni da parte del governo cinese, che lui forse è danneggiato dalla vaghezza del proprio governo; non tanto da quello in atto – che presto invece quasi vorrà emulare il cinese – ma proprio dalla stessa concezione di governo che egli ha introiettato dentro di sé in molti decenni di notizie a lui giunte dalla democrazia parlamentare italiana. È ovvio che tale vaghezza non è da associarsi esclusivamente alle virtù già indicate della democrazia liberale: c’è in ballo a questo punto, e in modo assai pesante, il grosso fardello di inefficienza, corruzione, superficialità, doppiopesismo, protezione di privilegi, collusioni mafiose, gravissima patologia burocratica, ingiustizia fiscale, incertezza della pena, sfiducia nella Giustizia, che caratterizza marcatamente le istituzioni italiane. L’italiano inizia ad ammirare la Cina: non tanto i suoi abitanti, che reputa ancora delle aliene formiche igienicamente incivili, ma il suo governo comunista dittatoriale, che racchiude in sé nella sua esecutività tutto ciò che l’Italia non è. Tale improvviso sbotto di ammirazione per l’efficienza del potere esecutivo, questo colpo di fulmine tra il cittadino di una democrazia parlamentare europea per la dittatura cinese, in realtà non è del tutto inspiegabile. Da diversi anni il pubblico italiano era stato attratto da temi e movimenti della cosiddetta antipolitica e, se poco sapeva delle istituzioni in sé, se non era in grado di spiegare a cosa esattamente servissero, molto era allenato ad additarle. Buona parte degli italiani viveva già da anni sulla propria pelle un progressivo impoverimento e una dilagante disoccupazione. Era poi tartassata notte e giorno da dibattiti su episodi di corruzione politica, criminalità comune impunita, interminati scontri ideologico/elettorali sull’immigrazione clandestina, subiva passivamente come qualcosa di ineluttabile nella sua incomprensibilità concettuale (per il cittadino medio fin qui disegnato) il succedersi di maggioranze parlamentari differenti all’interno della stessa legislatura. Il malcontento contro un’indefinita cosa pubblica era presente e vivo. Da diversi anni, inoltre, questo malcontento era stato intercettato, fomentato, organizzato e condiviso capillarmente mediante strumenti digitali contemporanei dal movimento della cosiddetta antipolitica, che al momento dello scoppio di Wuhan è al governo.
Ciò che il governo italiano sta per fare ha il terreno pronto.
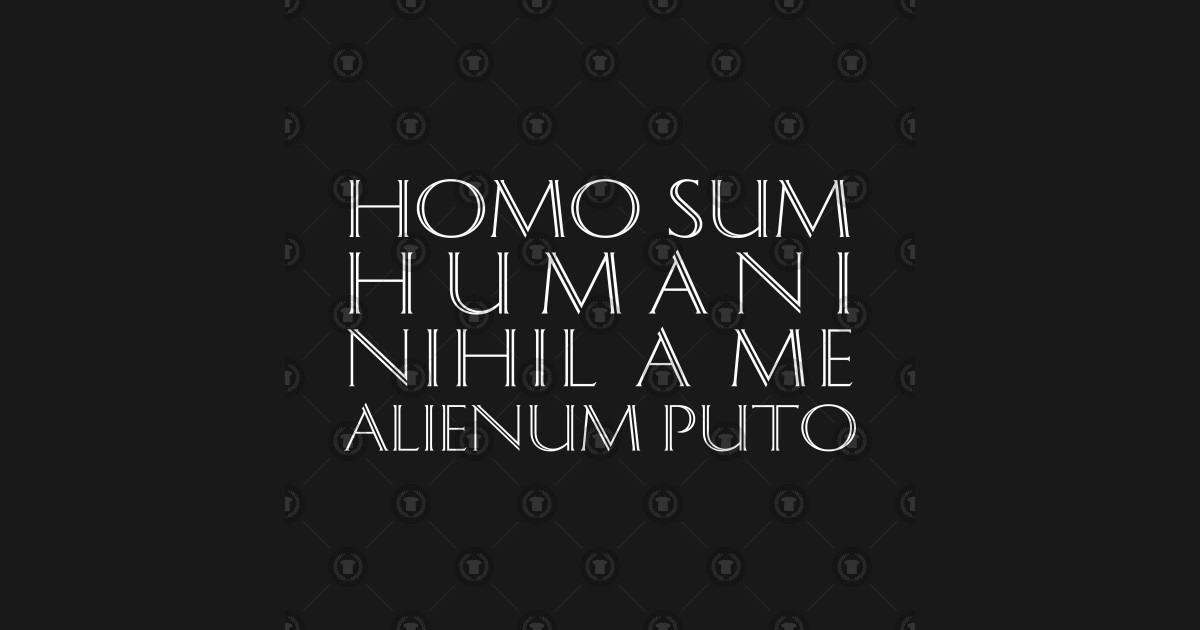
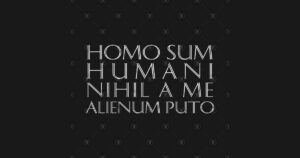
Caro Luca, capisco il tuo intetesse per questa psicopandemia da un tuo punto di vista professionale, ma anche umano direi, chi non sta cercando nel suo piccolo di capire cosa ci stia succedendo sul piano sociale vista l’escalation di trasformazioni relazionali in atto. Questo tuo tentativo di cercare con la massima obiettività le ragioni di tutto questo lo trovo interessante sebbene io pensi che una vera oggettività di pensiero non possa esistete, che nelle nostre analisi mettiamo sempre un po di noi, delle nostre idee radicate, delle nostre speranze o delle nostre paure. Così dal tuo scritto mi sembra di cogliere più una tua ammirazione per un regime dittatoriale cone quello cinese che con l’efficienza di azioni totalitarie e irrevocabili ha sconfitto nel breve tempo l’epidemia di Covid19. Personalmente, ma non credo di essere stata la sola, quando ascoltavo le notizie giungere dalla Cina di efferate azioni contro la popolazione cinese, a volte rimossa in modo coatto dalle proprie abitazioni perché aventi solo qualche linietta di febbre o per la denuncia di qualche vicino, mi ritenevo assai fortunata di non appartenere a quella società così oppressa nelle liberta individuali. Questi nostri due diffetenti modi di approcciarci alle vessazioni di un governo totalitario, il tuo lo hai voluto trasferire a tutta la popolazione italiana, sono anche alla base credo della diversa interpretazione che io e te diamo all’eventuale obbligatorietà di un vaccino, per te è il male minore per me sarebbe una gravissima violazione delle libertà personali, così come lo sono già i vaccini obbligatori per i minori e questo non perché io sia contro questi rimedi farmacologici a contrasto di certe malattie ma perché credo nel leggittimo consenso che ognuno dovrebbe dare nella tutela del proprio corpo. Quindi come vedi, sono il concetto di libertà e di democrazia che ognuno ha che determinano la visione di scelte politiche più articolate, se non partiamo dalle basi concettuali o psicologiche degli individui non riusciamo a vedere il significato di certe posizioni. Cmq io la pensi spero tu possa andare avanti nello sviluppo di questo tuo progetto.
Ciao Mariella,
Immagino che questa parte iniziale stimoli una critica come la tua. In realtà non si tratta tanto della mia preferenza o inclinazione (che ovviamente comunque puó manifestarsi in qualunque espressione personale) ma del tentativo di mettere il lettore, in un modo anche un po’ originale e provocatorio, sulla lunghezza d’onda che il saggio vuole mantenere, quella della logica della comunicazione di massa. Non è molto importante stabilire se è vero o meno che tutti gli spettatori italiani della TV abbiano “ammirato” la Cina (è ovvio che no), voglio intanto che il lettore entri nella logica che ció è possibile, anche probabile, per come, per il modo e i tempi secondo i quali le notizie hanno raggiunto tramite i media la popolazione italiana.
Mi serve soprattutto per gli argomenti a seguire.