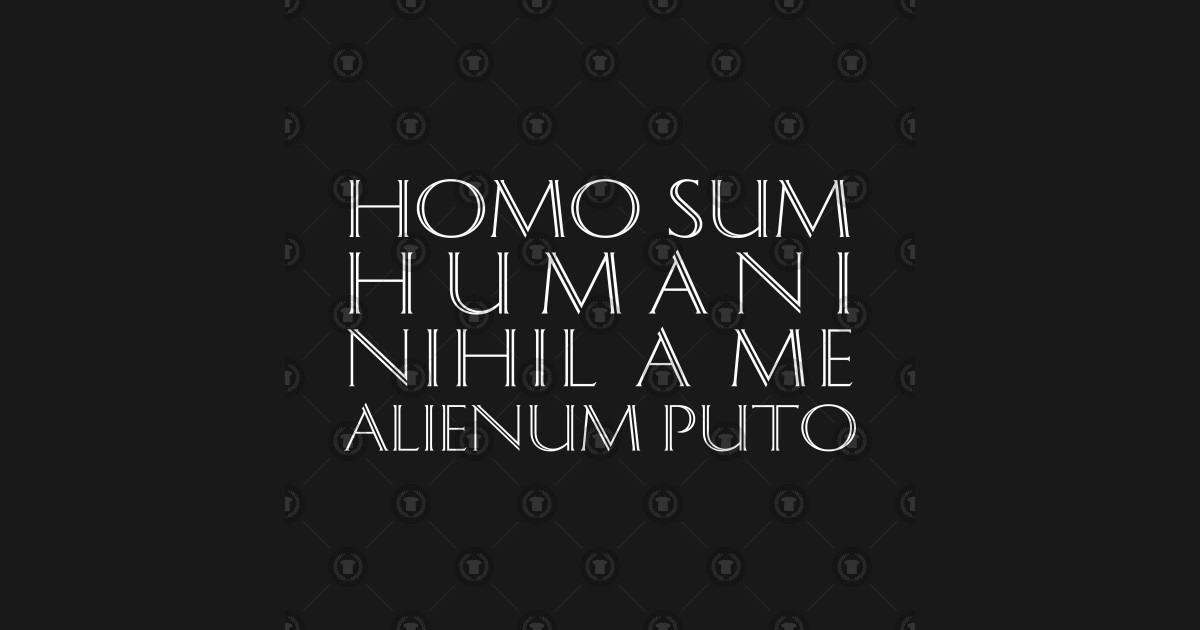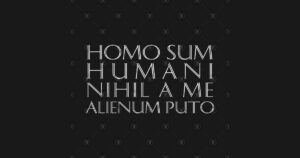
PUBBLICAZIONE N. 3
CAPITOLO II
Le reazioni psicologiche sociali
La tempestiva svolta autoritaria del popolo dei media è permessa dall’eccitamento di una definita dimensione psicologica che il virus ha improvvisamente stimolato: l’igiene. Il germe può infettarmi per contagio proveniente da un’altra persona, e può uccidermi, questo è assodato, è quanto viene confermato di continuo dall’informazione. Devo mettere in atto una serie di gesti per evitare di contagiarmi, un insieme di precauzioni che riguardano l’igiene. L’invito a lavarsi le mani, e le relative dimostrazioni di come ciò va fatto correttamente per ottenere un effetto davvero disinfettante, è talmente reiterato in TV da indurre nella popolazione un numero sconfinato di lesioni dermiche da irritazione. Il disinfettante Amuchina raggiunge una notorietà che è, per un prodotto di quella categoria, strepitosamente eccezionale, e si impone mediaticamente come un oggetto la cui disponibilità è indispensabile: evoca quella di un farmaco salvavita.
Ma l’igiene non è soltanto un insieme di protocolli precauzionali da agire contro precisi rischi di malattia. È un complesso di concetti e prassi che investe pienamente gli interscambi tra persone, le relazioni tra loro. Pratiche d’igiene sono l’occasione dalle quali scaturiscono alcune radici dello sviluppo psico-relazionale dell’individuo. Il primo contatto fisico umano che il bambino esperisce fuori dalla pancia della mamma si compie in occasione del bagnetto in sala parto. Le pratiche igieniche costituiscono poi presto le occasioni tramite cui la madre (o chi per lei) mette in atto l’accudimento del proprio bambino: l’allattamento, il cambio dei pannolini, i bagnetti. In queste prassi è contenuto l’embrione dello sviluppo psico-affettivo di quella persona che il bambino diventerà, l’imprinting della sua percezione dell’altro: se è accudente, protettivo, caloroso, gioioso, oppure distaccato, freddo, apatico. Per Freud è in occasione di questi gesti che nel bambino si accende l’eccitamento delle zone erogene orale, anale e genitale, così fondanti lo sviluppo della persona nella sua concezione psicoanalitica (fasi psico-sessuali). L’igiene, con i suoi riti, è profondamente condizionante la vita psico-relazionale della persona.
Il grado di vicinanza relazionale che ciascuno di noi vive con gli altri è certificato, sottotitolato, etichettato dal maggiore o minore livello di prossimità fisica, corporea, che consentiamo all’uno o all’altro: io bacio in bocca la mia fidanzata, ho rapporti sessuali intimi con lei; non bacio sulle labbra il cassiere della banca o il professore d’università. Da neonato è mia mamma ad allattarmi, non – in genere – un giorno una signora e l’indomani un’altra; anzi, è proprio perché mi allatta che si chiama mamma (da “mammella”). Io invito a cena in casa mia persone delle quali ho un grado seppur minimo di conoscenza/informazioni. Abbraccio i miei amici e i miei familiari, non gli estranei. L’igiene misura la distanza relazionale tra le persone. La stretta di mano, nella normale consuetudine, è un rito simbolico della reciproca disponibilità a superare le prime e più periferiche barriere igieniche: è l’apertura consensuale di una transazione che potrebbe (o no) approfondirsi in seguito, facendosi in quel caso via via igienicamente più compromettente. Quante amicizie, amori e matrimoni hanno avuto origine da una stretta di mano?
Il tam tam mediatico incessante sui gravi rischi del contagio mediante la semplice condivisone aerea con l’altro, il respirare nello stesso ambiente; la insistenza marcata dei media (soprattutto nei primi mesi di pandemia) sulla massima importanza del lavaggio assiduo delle mani e della loro disinfezione con prodotti specifici; la diffusione continuativa del messaggio indicante un alto rischio di contagio anche dal contatto con oggetti e superfici inanimate, sulle quali il virus – dicevano – sopravviveva per tempi straordinari, con le relative ingiunzioni di oculate e reiterate “sanificazioni”; le puntigliose disquisizioni sulle qualità filtranti delle differenti tipologie di mascherine, chirurgiche, ffp2 ed ffp3, e le confuse/contraddittorie indicazioni di quando fosse suggerito, opportuno od obbligatorio indossarle; il terrore degli “assembramenti”, parola fino ad allora in disuso e che avrà nei mesi a seguire una ossessionante fortuna; tutte queste strenue pressioni mediatiche hanno ovviamente scosso intensamente la psicologia collettiva. Perché messaggi di questo genere non rimangono a un livello solo superficiale, di semplice suggerimento di precisi gesti indirizzati alla protezione contro una specifica minaccia: arrivano in profondità, eccitano radici psicologiche fondanti l’individuo, il suo modo atavico di percepire gli altri e il mondo, tutto il suo stile di vita psico-relazionale. E più l’insieme di queste ingiunzioni igieniche mediaticamente veicolate è associato al rischio di morte, di distruzione della persona, più in profondità esso scuote queste radici.
Ecco che la massiccia campagna mediatica sulla pandemia, con le maratone di ore e ore al giorno di interrogativi sull’origine del virus, dimostrazioni su mascherine, mani e sanificazioni, le interviste fiume mai più interrotte a esperti virologi, igienisti, epidemiologi, sanificatori ecc., che arrivano a combattersi come guelfi e ghibellini, come fascisti e comunisti, si impone come la nuova “normalità” psico-sociale, la nuova igiene mentale collettiva. Questa “normalità” anormale – marcatamente anormale – eccita e sdogana quindi come “normali” quelle che nella precedente normalità – quella vera – erano bollate come attitudini nevrotiche, tratti di personalità disfunzionali, sfumature psicopatologiche. È un repentino ribaltamento dei parametri psicologici condivisi: ciò che ieri era giudicato anomalo, quella che era una palese fisima, una fragilità, un’idiosincrasia psicologica del singolo, ora si trasforma in virtù sociale. Le categorie psicologiche immediatamente più stravolte sono quelle fobico/ipocondriaca e ossessiva, tradizionalmente accomunate – nel caso dei quadri clinici veri e propri – nel capitolo delle nevrosi d’ansia.
Le paure di contaminazione proveniente dal contatto con gli altri sono sempre state enormemente diffuse, a prescindere da specifici rischi infettivi. Si tratta, come sintetizzato più su, di tendenze risultanti dai più atavici modelli di relazione fisica con il prossimo, condizionanti la fiducia, la vicinanza che a lui possiamo concedere: se è stretto e fidato, o estraneo e sospetto. Nel tempo ordinario queste piccole fobie si risolvono in abitudini quotidiane di poco rilievo e, in genere, volutamente non manifeste agli altri, se non deliberatamente celate: c’è chi non si accomoda mai in ambienti pubblici su sedie e poltrone utilizzate da altri; un’enorme quota della popolazione non utilizza bagni pubblici neanche in condizioni di urgenza fisiologica; qualcuno non si avvicina mai al prossimo oltre un limite metrico da sé stabilito. Esiste una rilevante percentuale di persone che converte in mansioni domestiche di pulizia parti importanti della propria irrequietezza psicologica, dell’ansia, della necessità di controllo, spesso anche della vera e propria rabbia. La donna che si affaccenda di continuo in casa con ramazze, pezze e aspirapolvere è una realtà sociologica, non solo un cliché da antica barzelletta de “La Settimana Enigmistica”: pulisce, ordina e stravolge casa non tanto perché ve ne sia un’oggettiva necessità, ma per consumare energia psichica in qualcosa che sia comunque utile, una sorta di conversione virtuosa, che impedisca quella patologica, quella che diventa sintomo. Fin qui siamo nel range delle varianti in cui si organizza, si mantiene, si esprime e trova un suo equilibrio psicologico dinamico quella che – con un concetto utile ma necessariamente riduttivo – chiamiamo normalità. Le vere e proprie nevrosi d’ansia rappresentano la vetta psicopatologica di questa enorme diffusissima mole di tendenze psicologiche normali. Le nevrosi, affermava Freud, non sono altro che intensificazioni, accentuazioni, esagerazioni marcate di meccanismi psicologici presenti nella normalità. Il DOC, con le ossessioni e le compulsioni che arrivano a un livello tale da interferire con il benessere psichico, la produttività e la socialità dell’individuo affetto, è incentrato spessissimo sui temi e i riti dell’igiene: l’ossessivo che si lava le mani decine di volte al giorno e che arriva a rovinarsele gravemente per l’utilizzo compulsivo di disinfettanti aggressivi è una figura classica della psichiatria. È assillato in modo patologico dal dubbio di una contaminazione con germi portati al suo cospetto dagli altri. Fobici ossessivi o ipocondriaci sono molto spesso impauriti dai normali contatti sociali. Soggetti che non danno la mano, utilizzano perennemente guanti, non toccano le maniglie delle porte se non con i gomiti, hanno sempre dappresso disinfettanti con cui s’impegnano in volenterose “sanificazioni” di quegli invisibili pezzi di “altro” – i germi – lasciati sul tavolo, sulla tastiera del PC, sul telefono, come mine che possono essere loro fatali. L’ossessivo fa queste cose con la dolorosa consapevolezza che si tratta di fobie, di esagerazioni assurde: questa consapevolezza è la controprova di quanto siano potenti le originarie matrici psicologiche connesse all’igiene, che innescano sofferenza emotiva quand’anche la razionalità della persona stessa trova ingiustificate queste paure di contagio.
La pandemia mediatica ha stravolto il modo di stare al mondo di tutti coloro che si possono includere in questo grande contenitore. Perché essi sono rimasti uguali, ma i parametri di “normalità” nel mondo si sono ribaltati. I media veicolano per decine di ore al giorno inviti alla paura della contaminazione, alla puntigliosità e ripetitività delle sanificazioni, alla massima attenzione nell’attenersi al “distanziamento sociale” (un termine errato linguisticamente, che evoca differenze di ceto, e che andava prontamente sostituito con “distanziamento fisico”). È la piena rivincita sociale degli ipocondriaci/ossessivi: improvvisamente il mondo dà ragione alle loro paure, alla loro perenne ansia, al loro spasmodico bisogno di controllo. Le loro attitudini non sono più fisime e malattie, sono virtù sociali. C’è un invito costante e massiccio inviato dai media al popolo a divenire ossessivo. Per l’ossessivo e l’ipocondriaco vero, e per tutto il sottostante enorme numero di persone che condividono uno “spettro” fobico/ossessivo, è l’occasione per riallineare emozioni e ragione, dunque per sentire finalmente un sollievo dalla sofferenza nevrotica, dal conflitto interno, un sollievo ampio quanto il mondo stesso: non si liberano affatto dalle loro paure, si liberano dal penoso conflitto che fino a poco prima la loro razionalità muoveva contro di esse. Si liberano dell’autocritica contro queste paure. Ora la razionalità non deve più combatterle, deve anzi promuoverle a testa alta. La nevrosi è sparita, non c’è più il conflitto interno: Es, Io e Super-Io sono allineati. Possiamo quindi affermare che la “categoria” dei fobici/ossessivi vive – su un piano esistenziale e sociale – meglio in pandemia che al di fuori di essa, perché assume per la prima volta una certa autorevolezza psicologica sociale. Questa si fa rapidamente voce pubblica: i social rappresentano perfettamente la popolazione. È in essi che si delineeranno e prenderanno voce le differenti categorie psicologiche di massa eccitate dalla possente campagna mediatica pandemica.
“Restate a casa!” è un importantissimo slogan/mantra dell’intera campagna pandemica, che esplode in Italia insieme all’ “Andrà tutto bene!” negli straordinari mesi del lockdown della primavera 2020, caratterizzata anche dai canti sul balcone. Il “Restate a casa!” è un punto di radicale svolta per un’altra ampia fetta psicologica della popolazione, composta da vari sottogruppi, come vedremo anche sostanzialmente diversi tra loro, ma accomunati da un elemento: la poca tendenza sociale, o quantomeno la scarsa attitudine alle frequentazioni fisiche, “in presenza”. “Schizoide” è un termine che in psichiatria si utilizza per indicare un’abnorme assenza di interesse e motivazione al contatto relazionale con gli altri, e dunque una conseguente tendenza alla introversione solitaria: il Disturbo di Personalità Schizoide è un’entità ufficiale della nosografia internazionale. Il quadro pieno e conclamato riguarda una minoranza esigua epidemiologica, ma quote nucleari del corteo sindromico sono piuttosto diffuse nella popolazione generale: i cosiddetti “tratti” di personalità. Soggetti infastiditi dal contatto sociale ne esistono molti, anche non prettamente catalogabili come patologici. È del tutto automatico che il lockdown, e soprattutto il “Restate a Casa” come comandamento, abbiano costituito per essi un salto lungo dalla “stranezza”, dal disadattamento, da un’attitudine negativa, alla vera e propria virtù civile. Anche in questo caso, l’anomalia si trasforma nel suo opposto.
A prescindere poi dalla minore o maggiore quota di vera apatia sociale, gente che normalmente sta sempre e “troppo” a casa per i fatti propri ce n’è tanta. Pensiamo ai giovani che nel tempo ordinario passano gran parte del tempo chiusi nella loro camera, riducendo al minimo i contatti anche con familiari e conviventi. Quanti sono i genitori che nella nostra epoca si sono trovati a esortare i propri figli ad abbandonare finalmente il PC o lo smartphone, la propria cameretta di isolamento, la Playstation, per andare a fare attività motoria o a incontrare fisicamente i propri amici? Improvvisamente questo paradigma si ribalta. Non solo diventa virtù, valore civile e quasi una “competenza” il saper stare molto tempo chiusi a casa, ma si compie anche la grande rivincita delle tecnologie digitali spadroneggiate dai giovani – con i loro tablet, giochi e smartphone – nei confronti delle lagne e lamentele per un ritorno ai bei tempi che furono, a quando “ci si incontrava davvero” o si “giocava all’aria aperta”, dei genitori. I figli stanno a casa molto meglio degli adulti, vi sono ben più abituati: la loro socialità è già da molti anni sbilanciata sulle vie digitali. Il pigro ipomobile sempre adagiato sul letto o sul divano diventa ora un eroe civile, dacché era un mezzo degenerato, e la sua capacità di utilizzare le tecnologie digitali lo eleva di rango all’interno di casa: sarà lui il più delle volte durante i mesi del lockdown a cercare di penetrare il sito dell’INPS per le richieste di bonus, a inviare email per consegne a domicilio di spesa e altri generi di consumo, a consentire i collegamenti in video-chiamata per i contatti familiari e d’amicizia, a rendere fattibile la famigerata DAD (Didattica a Distanza). Una rivoluzione psicologica sociale: il vizio si ribalta in virtù.
In questo ampio contenitore dei “comodi a casa” citiamo rapidamente coloro che rientrano o si avvicinano per “spettro” al quadro di fobia sociale, quelle persone che in generale vivono con un eccesso di emotività il loro interagire con gli altri. Si macerano nell’ansia oppressi dalla costante paura di ricevere da se stessi e dagli altri un giudizio negativo sulla propria performance, il terrore di fare una “brutta figura”, sia in ambito produttivo, sia in ambito socio/affettivo. Il liceale che si sente (e spesso lo è) emarginato dai pari e trema ed è inibito in classe, il/la giovane adulto/a che vivono con il terrore della delusione la ricerca di un partner affettivo, il professionista in apparenza grintoso che va in preda a crisi d’ansia quando sa di dovere parlare in pubblico.
L’Agorafobia da Attacchi di Panico consiste nell’evitamento di luoghi e spazi considerati dalla persona che ne è affetta rischiosi per lo scatenamento di crisi perché, nella sua immaginazione condizionata dall’ansia, difficilmente raggiungibili da soccorso immediato, o particolarmente stimolanti l’ansia, o inadatti logisticamente a nascondere agli altri l’eventuale malessere acuto di cui ci si vergogna. Si tratta di una condizione enormemente diffusa. La casa è molto spesso, per chi è in preda a questo disturbo psichiatrico, l’unico luogo sicuro; ma finché il mondo gira come sempre, normalmente, essa rappresenta con le sue mura penosamente invalicabili l’emblema della nevrosi dell’agorafobico, ne è allo stesso tempo rifugio e prigione, consolazione e pena. Perché lo rassicura dal malessere, ma è la cella dentro cui sono chiuse le sue aspirazioni, le sue inesaudibili voglie di esplorazione del mondo. Con la pandemia, con l’esaltazione civica del “Restate a casa!”, anche questo rapporto tra l’Io e la casa, così cruciale nella nevrosi panica, viene ribaltato. Restare chiuso in casa per mesi non è più sintomo di una malattia, improvvisamente è segno di valor civile. Si tratta di un ribaltamento psicologico, una variazione del rapporto Sé-Mondo. Lo slogan mediatico mira a ottenere un rapido effetto pratico, il contenimento dei contagi, ma non sembra curarsi minimamente della psicologia delle masse, degli effetti che induce sui parametri di normalità.
L’endemica dipendenza da cannabis si associa spesso, nella nostra esperienza, al ritiro domestico. I giovani contemporanei, inclusi come fasce di età dall’adolescenza fino ai trent’anni, hanno in generale, nella nostra esperienza, una maggiore tendenza a trascorrere in casa il loro tempo libero rispetto a quanto non facessero alla stessa età i loro genitori. L’“uscire”, l’allontanarsi fisicamente da casa e dai familiari era più essenziale allo sviluppo di relazioni amicali, alla possibilità di divertimento, all’incontro erotico, al compiersi di un’autonomia rispetto ai familiari, nei decenni finali del XX secolo. È verosimile che la perenne connessione interpersonale garantita dalle tecnologie digitali dentro le quali gli attuali giovani sono nati e e cresciuti abbia avuto un peso in questo cambiamento di abitudini “spaziali”. A noi sembra che anche il consumo di sostanze stupefacenti, e in particolare quello globalmente endemico di cannabis, si associ oggi a riti sociali differenti da quelli in auge durante la giovinezza degli attuali genitori. Il giovane “accannato” cronico che resta per settimane a casa, immerso in uno stato di “tranquillità”, tutta vissuta sul divano a giocare alla playstation o a guardare serie TV, è sensibilmente diverso dal prototipo del giovane spinellato degli anni Ottanta/Novanta, che cercava più un effetto di disinibizione sociale, analogo a quello associato tradizionalmente all’alcool. La cannabis è sempre più una droga da ritiro, che ti “rilassa” dallo stress dei continui stimoli cui il mondo sociale ti sottopone, sia produttivi che affettivi. Viene oggi cercato in essa un effetto più introvertente, mentre nei decenni precedenti fu più un lubrificante relazionale, un disinibente la timidezza, i “complessi di inferiorità”, una spinta all’euforia socializzante ed esplorativa del “fuori”, oltre che un ostentato vessillo di trasgressione anti-borghese di minoranza. Anche nei confronti di questi numerosissimi soggetti, diremo pigri e “cannabinati”, con il “Restate a casa!” deve all’improvviso spegnersi il biasimo, la critica pedagogica serrata e spesso moralistica che cadeva loro addosso fino al giorno prima da parte di genitori, tutori, insegnanti, o anche soltanto – nel caso diffusissimo di famiglie poco dedite alla pressione educativa – di modelli sociali ideali assimilati mediaticamente. Il “Restate a casa!” ossessivo messaggio di virtù civile sovverte pertanto i parametri psicologici ed etici di tutti coloro per i quali fino al giorno prima il restare a casa era stato additato come un vizio.
Questo nostro affondo sugli effetti psico-sociali dei messaggi mediatici connessi alla pandemia si è mosso dalla indicazione di categorie tipicamente psichiatriche, nosografiche, dunque patologiche. La fobia sociale, il disturbo da attacchi di panico, la tossicodipendenza, sono considerate patologie vere e proprie, e in quanto tali sono minoritarie nella popolazione. Ma esse qui servono solo da bussola di orientamento generico per approfondire poi il nostro sguardo dentro la popolazione generale, in quanto le categorie psichiatriche sono in gran parte le punte di enormi iceberg, di vastissimi gruppi di persone “normali” caratterizzate tuttavia da piccole nevrosi, da “tratti” di personalità, da sintomatologie psichiche sotto-soglia, da tutte quelle differenti caratteristiche personologiche che nel complesso formano, appunto, la “normalità” psichica.
Nella Schizofrenia Paranoide e nel Disturbo Delirante le convinzioni di essere perseguitati giungono a un livello tale da compromettere il funzionamento produttivo, relazionale e fisico della persona. Ma la tendenza alla sospettosità, la dietrologia come attitudine dello sguardo sugli eventi del mondo, la reinterpretazione in chiave egocentrica (“è rivolto a me”) di messaggi ed eventi generici, sono diffusissime nella popolazione generale cosiddetta normale. Fanno parte della variegata dotazione psicologica umana, che prevede il fiducioso e il diffidente, lo scettico e il dogmatico, l’ottimista e il pessimista. C’è quello che crede nel caso, che non intravede quindi un preciso filo unico causale, una o più specifiche volontà nell’avvio e nella connessione tra loro degli eventi, da A a B, da B a C, da C a D ecc., e dunque vede i fatti sovrapporsi, mescolarsi, interferire tra loro a prescindere da un nesso lineare; un altro, invece, tenderà di più a queste ricostruzioni in serie, da percorrere a ritroso, come un racconto da esaminare al contrario, analogamente a un’indagine su un delitto, partendo dall’epilogo fino a scoprirne l’autore. “Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio” potrebbe essere lo slogan non del tutto irragionevole di quest’ultimo. Il vero e proprio malato delirante è stravolto il più delle volte rapidamente da convinzioni assurde, che sono per comparsa e intensità un fatto psichico nuovo, rivoluzionario rispetto al suo assetto mentale precedente, normale. È proprio la brusca variazione che costituisce, che “fa” la malattia, da un prima in cui vi è un equilibrio individuo/mondo che dura da sempre, stabile da molti anni, a un dopo in cui il mondo si è trasformato rapidamente agli occhi del malato in un ambiente inquietante, ostile, pregno di messaggi oscuri, di imminenti pericoli. Il giovane al primo episodio psicotico è sconvolto dalla “scoperta” che la madre, il fratello o l’amico del cuore vogliano ucciderlo. Ben diversa è la diffidenza stabile, “caratteriale”, diremo costituzionale della persona, così come la tendenza atavica a reinterpretare in chiave narrativo-complottistica gli eventi: queste non costituiscono da sole quadri patologici, sono – lo ribadiamo – tratti, attitudini, modi di guardare al mondo, formae mentis, assai diffuse nella popolazione normale, che non portano nella stragrande maggioranza dei casi alla paralisi dell’esistenza, alle gravi complicazioni individuali tipiche delle malattie mentali.
Le teorie del complotto non sono un’invenzione contemporanea. Si pensi, ad esempio, a quanto l’intera storia dell’antisemitismo sia stata alimentata da molteplici secolari elucubrazioni storiografiche, da miscugli di sentimenti di paura, ammirazione, odio religioso, invidia economica, suscitati nei secoli dalla peculiarissima storia e identità del popolo di Israele; un’identità fortissima che evidentemente ha consentito a questo popolo, già biblicamente “eletto” anche per i cristiani, un’eccezionale coesione e una resistenza millenaria alla più ampia dispersione geografica, e al più tragico genocidio della Storia. Assai famoso il caso preconfezionato di stimolo alla teoria del complotto antisemita rappresentato dal pamphlet “I Protocolli dei Savi di Sion”, un falso redatto apposta dai servizi segreti russi/zaristi, che del miscuglio di mezze verità, suggestioni e paure si alimentò, e che a sua volta contribuì molto a potenziare. È solo un esempio di come un oggetto straordinario (in questo caso il popolo di Israele) possa accendere nelle masse reazioni e immagini appunto straordinarie, a prescindere dalla abnormità della massa, da quanto essa sia “malata”: non dobbiamo illuderci che tutti i nazisti che trucidarono ebrei fossero dei casi clinici di psichiatria; no, la realtà è più inquietante, essa prevede che abomini come la Soluzione Finale si possano insediare come “giusti”, “benefici” e addirittura indispensabili nella mente di grandi numeri di persone tecnicamente sane di mente. É stata la straordinarietà dell’oggetto “ebrei”, “popolo di Israele”, che ha acceso l’immaginazione delle masse: qualcuno negli anni Venti e Trenta del XX secolo se n’è accorto e ha deliberatamente utilizzato questa immaginazione eccitata della massa, la ha strumentalizzata in modo abominevole e mostruosamente efficace.
Una pandemia mondiale improvvisa è la perfetta occasione di eccitamento delle normali e diffusissime attitudini alla sospettosità presenti in una popolazione. Questo dovrebbe essere previsto da chi ha delle responsabilità politiche di gestione di un fatto così epocale, unico.
Abbiamo visto come si sia costituita in Italia nel marzo 2020 nel giro di pochi giorni un’entità molto potente, di natura psico-sociale ancorché politica, poiché nutrita e sostenuta intensamente dalla campagna mediatica relativa alla pandemia, e dalle naturali paure che questa fa esplodere nei cittadini: questa entità è il governo italiano. “Governo” era un concetto politico/giornalistico vago per la gran parte dei cittadini italiani; diventa all’istante una potente autorità che è in grado di introdursi nella vita quotidiana e finanche corporea dei singoli. La comparsa così repentina di un’autorità forte è un evento straordinario sul piano psicologico, che ha ovviamente effetto sui sospettosi di natura. Questa sospettosità quiesciente e normale è immediatamente eccitata insieme alle fantasie dietrologiche per via di TG, talk shows, approfondimenti ininterrotti che per ore e ore al giorno discettano sui temi intricati della pandemia. I media, i singoli network, i tanti giornalisti, inviati, redattori, direttori, opinionisti, colgono la pandemia come un invito a nozze e, anche se in perfetta buona fede – cioè convinti di contribuire a una corretta informazione di massa – altro non fanno che aumentare in questa fase il proprio prestigio sociale. Un terribile potere quello dei media, che si accresce all’intensificarsi dell’emergenza, e che alimenta, con gli interminabili sempre più urgenti “approfondimenti” (dallo share d’eccezione anche per via del lockdown che ha chiuso in casa decine di milioni di italiani) la sensazione stessa di emergenza, eccitando un circolo vizioso che premia sempre e solo una categoria sociale: i media stessi.
Nella vicenda covid c’è un elemento originario che si presta classicamente ai complottismi, alla dietrologia: la provenienza del virus dalla Cina. Il gigante giallo è una dittatura comunista il cui governo è in grado di manipolare qualunque informazione, e che già da molti anni incute nei popoli occidentali timori invasivi, basati sulla sua inarrestabile espansione economica. Moltissimi guardano alla Cina con sospetto già da tanto tempo, non c’è bisogno di essere paranoici per farlo. Se la Cina è da sempre una superpotenza pericolosa per l’Occidente (la sua storia comunista incide pesantemente sulle schiere italiche contrapposte di suoi accusatori da un lato e simpatizzanti dall’altro), l’improvvisa comparsa di un’autorità in Italia che ne imita l’efficienza esecutiva eccita oltremodo le menti. La convinzione “negazionista”, ovvero che non esista in realtà nessun nuovo pericoloso virus, e che quindi vi sia in atto un globale complotto mediatico, prende piede e si pone però in contraddizione con l’altra tesi del complotto: la Cina ha deliberatamente prodotto e liberato contro il resto del mondo questo nuovo coronavirus, che pertanto non è il frutto di una evoluzione naturale ma un’arma infettiva costruita in laboratorio. Ci sono dunque fazioni contrapposte anche all’interno dei gruppi caratterizzati psicologicamente dalla diffidenza: il virus non c’è, i morti sono quelli annuali dell’influenza ora ricatalogati come covid da un gigantesco cartello mediatico complottistico; no, il virus c’è, ma non è naturale, è un atto di guerra della Cina espansionista contro il resto del mondo. Il complottista, il negazionista non è affato un malato, e neanche necessariamente un “ignorante, analfabeta funzionale”, riferendoci a termini che hanno accompagnato per mesi diatribe social tra fazioni opposte: è un soggetto normale straordinariamente eccitato nelle sue tendenze psicologiche interpretative da stimoli palesemente straordinari. La sua risposta non è differente nella forma, nella modalità, da quella già descritta dei tantissimi “fissati” con l’igiene: anche lui, come questi ultimi, trova nella pandemia mediatica l’occasione per dare libera espressione alle proprie tendenze, che nel tempo ordinario tiene a bada con un certo sforzo di auto-contenimento. La pandemia mediatica è un contesto che libera dall’autocontrollo le psicologie, le quali riscoprono come virtù quelle che sono considerate nel tempo ordinario le loro nevrosi. Viene accolta a livello individuale, in larga parte, diversamente da quanto appare in superficie, come un’improvvisa psicoterapia d’urto.