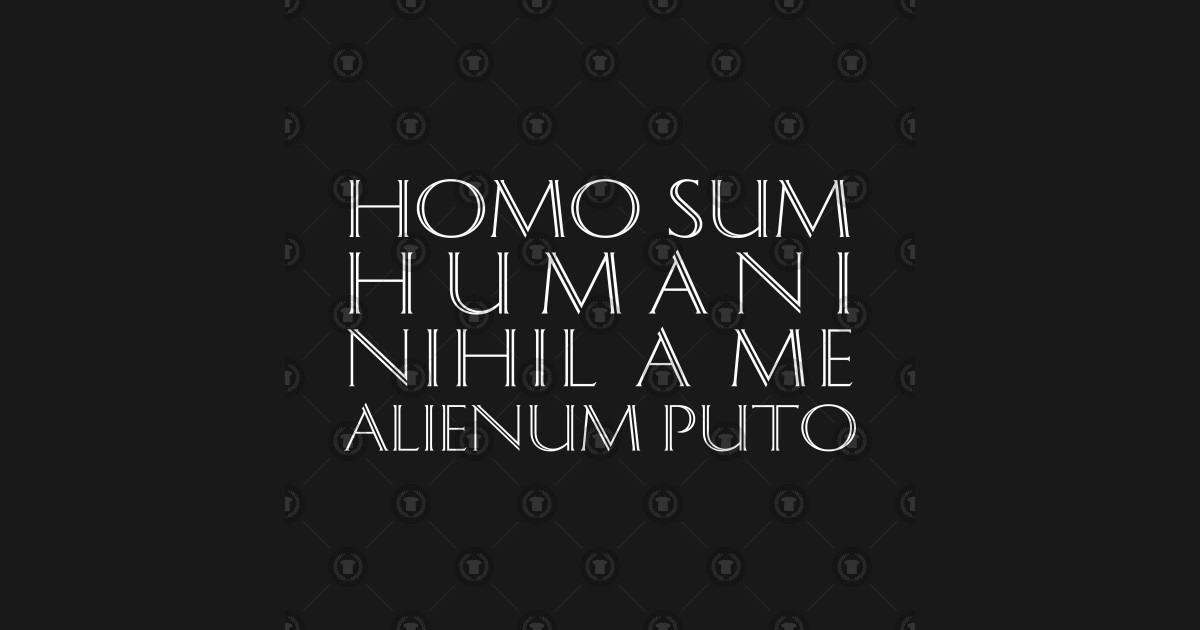PUBBLICAZIONE N. 4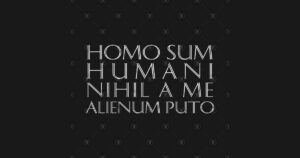
CAPITOLO III
Lo “scontro” civile
Sono poste a questo punto le basi per quella che diventerà la più intensa contrapposizione in Italia di parti della popolazione dagli anni di piombo in poi. Se è vero che normalmente i gruppi di tendenza fobico-ossessiva convivono pacificamente, e anzi inconsapevolmente, con quelli paranoico-dietrologici, in questa situazione lo scontro è eccitato dalla incessante attività propagandistica del governo e dei media. Le molte apparizioni in TV a reti unificate del Presidente del Consiglio che spiega nei dettagli quali singole azioni fisiche sono “consentite” dai suoi numerosi DPCM e quali no; le innumerevoli dimostrazioni in TV su come si devono lavare le mani per “sanificarle” davvero; le quotidiane conferenze stampa delle 18.00 del Capo della Protezione Civile, somiglianti a un ritualistico e funereo bollettino di guerra, sono esempi di intensi, straordinari stimoli mediatici che spaccano in due il Paese psicologico, e che avviano la polemica tra fazioni. Il governo e la propaganda mediatica martellano con intensità eccezionale sulla indispensabile urgenza dell’utilizzo delle mascherine, del distanziamento cosiddetto sociale, del lavaggio reiterato delle mani (classicissimo rituale ossessivo), del divieto di assembramento, parola fino ad allora ignota al grande pubblico e che avrà una lunga fortuna tutta intrisa di moralismo. Chi non si attiene a queste determinanti misure imposte per legge va perseguito in quanto persona che mette a rischio la salute pubblica. Il governo ha scelto in modo perentorio: vietare ai cittadini di uscire di casa, di fare gruppo, imporgli di respirare attraverso una maschera, non sono violazioni della libertà personale, sono regole obbligatorie di salvaguardia sociale. Il messaggio è chiaro: le prerogative di scelta del singolo sono ampiamente posposte all’interesse collettivo. È una scelta politica pienamente legittima. Il fobico/ossessivo, però, ne è conquistato per motivi psicologici, non politico-sanitari. Le imposizioni igieniche che per il governo altro non sono che istruzioni pragmatiche per ottenere un risultato epidemiologico, per contenere il numero delle ospedalizzazioni e delle vittime, per il fobico/ossessivo costituiscono una sollevante conferma di quanto giuste e realistiche siano le sue più ataviche paure, le quali in precedenza aveva sempre dovuto mistificare con sforzo, e che ora invece lo distinguono come un cittadino virtuoso, adeguato e soprattutto realista, nel senso che finalmente gli si riconosce di avere avuto sempre ragione sui rischi igienici della vita di contatto con gli altri, e fatto davvero rivoluzionario, egli adesso è ufficialmente supportato dalla “scienza”. Il governo, infatti, cita continuamente il CTS, il suo Comitato Tecnico Scientifico, costituito da esperti virologi, epidemiologi, infettivologi, igienisti. Il governo sottolinea costantemente nelle sue comunicazioni di massa di essere guidato nella redazione delle scelte restrittive dalla “scienza”, coagulatasi nel CTS. E le TV sono invase dai virologi.
Ecco che la convivenza pacifica di enormi gruppi psicologici differenti presenti nella popolazione generale si inizia a trasformare in conflitto politico. Ma sarebbe più corretto dire in scontro psico-politico. I gruppi paranoicali sono automaticamente diffidenti nei confronti dei diktat provenienti dalla improvvisa trasformazione autoritaria del governo italiano, oltre che pesantemente sospettosi nei confronti della Cina e dei media “mainstream”. I gruppi fobico/ossessivi, spesso connotati da esigenze moralistico/normative, diventano automaticamente filo-governativi, perché le misure di contenimento premiano la loro costituzione psicologica, non solo contenendone la paura nei confronti del virus, ma anche e soprattutto dando a essi ragione sulla visione complessiva della vita di relazione: incontrare gli altri è rischioso.
Queste considerazioni di psicologia sociale non vogliono essere – lo ribadiamo – una ricostruzione puntualmente storica di ciò che avvenne nel 202o in Italia. Si tratta, dato il genere della disamina, di valutazioni che possiamo indicare come macro-psicologiche, ovvero indicanti grosso modo, in senso generale, quali siano state le ricadute psicosociali in Italia della propaganda governativo-mediatica sulla pandemia. Non è nostra intenzione disegnare un contesto con limiti netti, definito in modo ineccepibile, secondo una logica deterministica, che sarebbe totalmente sganciata dalla realtà. Ad esempio, le appartenenze partitiche hanno certamente avuto un ruolo, indipendente dai tratti psicologici, nel formarsi delle fazioni polemicamente opposte tra loro, come lo hanno da sempre in Italia. Ed è anche evidente che la popolazione è in buona parte composta da persone in cui non spiccano i tratti descritti, e che sono dunque più portate a vivere le restrizioni come indicazioni solamente pragmatiche; una costituzione personologica che però le tiene verosimilmente più distanti dalle infervorate polemiche tra fazioni, facendole pesare/apparire poco sul piano mediatico e sui social. L’Italia è piena di cittadini che non si riconoscono né come “negazionisti” né come “scientisti”. Pur messe in conto queste realistiche precisazioni, una traiettoria psico-sociale complessiva della trattazione mediatica in Italia della pandemia covid è tracciabile.
La comunicazione imponente che il governo improvvisamente autoritario fa delle proprie scelte restrittive, e il complesso della propaganda mediatica di esse, crea il conflitto psico-sociale tra gli italiani al tempo del covid. Questo conflitto è consistito per grandi linee nell’affrontarsi di una fazione complessivamente filo-governativa/”scientista”/aderente ai DPCM Conte contro un’altra genericamente anti-governativa/ “negazionista/complottista”/ “libertaria”, e sebbene si sia consumato soprattutto sui social networks, ha previsto anche diversi episodi di protesta fisica, con scontri e manifestazioni di piazza.
C’è da chiedersi se gli addetti alla comunicazione del governo avessero previsto l’intenso conflitto polemico sociale che è esploso tra gli italiani, soprattutto dall’estate 2020 in poi, relativamente ai temi della pandemia. E ancor più bisogna chiedersi se il governo italiano esercitò o meno un ruolo attivo di influenzamento delle linee editoriali dei grandi network, o se questi furono totalmente indipendenti dall’esecutivo nella trattazione dei temi covid. Si pongono in ipotesi due scenari ben diversi: il primo nel quale il governo ha una sua linea, ovviamente pro-restrizioni, ma non concorda con i grandi network nazionali l’orientamento complessivo sui temi pandemici, non viene tra loro condivisa una sinergia studiata; il secondo scenario in cui – sebbene in modo non esplicito per il pubblico – questa sinergia è invece messa a punto. Se diamo per assodato che il conflitto psico-sociale, culturale, la guerra civile delle opinioni, ha avuto luogo, è opportuno confrontare questo dato acclarato con l’una e l’altra delle due possibilità indicate.
Nel primo caso (non vi fu sinergia preordinata tra governo e grandi network) si potrebbe a prima vista assolvere il governo dalle responsabilità principali di avvio del conflitto, che peserebbero di più, per la loro potenza comunicativa di massa, sui media, avvinghiatisi con voracità e ossessivamente alla trattazione dei temi pandemici che hanno diviso gli italiani. Se il conflitto sociale fosse una colpa (cioè se fosse acclarato che esso ha creato più danni che vantaggi, cosa non affatto scontata), sarebbe in tal caso – a un primo sguardo – a carico dei media “liberi”, non subordinati al potere politico. Ma a guardar bene, si paleserebbe a carico del governo uno squilibrio dell’azione: un esecutivo che può limitare la libertà fisica di decine di milioni di italiani, impedendone il passeggiare, vietando il semplice incontro tra persone non congiunte, chiudendo d’autorità centinaia di migliaia di scuole, industrie, uffici, esercizi commerciali, ecc., perché non può intervenire sulle modalità di trattazione della pandemia da parte dei principali media? Perché non può esercitare un potere di redazione centralizzata delle informazioni di massa riguardanti l’emergenza covid? Oppure potrebbe ma sceglie di non farlo? Se all’interno di questo primo scenario, quello di un mancato coordinamento tra governo e media, consideriamo il conflitto civile sul covid un “male” (cioè come fosse un’ostacolo alla lotta contro la pandemia, o comunque una tensione sociale dannosa) ne traiamo che il governo avrebbe dovuto dirigere, al fine di evitare questo “male”, il complesso dell’informazione mediatica relativa al virus, così come ha diretto la vita corporea dei singoli. Se ha scelto di non farlo pur avendone il potere– sempre nell’ipotesi che il conflitto sia un “male”- si può attribuire al governo la responsabilità di questo “male”, quantomeno colposa.
Se il governo invece non ha il potere – e non la volontà – di subordinare a sé le linee editoriali dei grandi networks, neanche con decreti speciali, data l’emergenza, si evidenzia una palese sproporzione tra il suo potere restrittivo delle passeggiate del cittadino fisico (prese come simbolo della vita individuale) e la sua impotenza di fronte ai colossi mediatici che influenzano l’intera popolazione. Data la grave emergenza, come risulta necessario ridurre la libera determinazione dei singoli, sarebbe altrettanto determinante far sì che l’informazione non procuri danni alla nazione. Il governo figura, in questo caso, con meno potere dei media, incapace di prevenire e bloccarne l’azione divisiva del popolo. Di fatto, in questo caso, i media dominano anche sul governo.
Nel secondo scenario più sopra indicato, quello in cui governo e media abbiano mantenuto una linea concordata, il governo è dolosamente colpevole del conflitto, ne risponde pienamente. Sempre che questo sia una colpa. Non è detto.
Perché lo scontro psico-cultural-politico che abbiamo indicato potrebbe anche non essere un “male”. Si potrebbe ipotizzare che l’ossessione mediatica italiana per la pandemia, e gli scontri tra le fazioni indicate, siano stati prodotti mediaticamente ad hoc, cercati come una strada efficace per tenere accesa l’attenzione e la paura degli italiani. Lo scontro, che ricalca quello ultra-secolare italico tra guelfi e ghibellini, fascisti e comunisti, le storiche sfide Bartali/Coppi, Juve/Inter, ovvero il modus tradizionale del dibattito pubblico italiano, è voluto, o quantomeno previsto come un epifenomeno, un effetto sociale prodotto dalla corsa verso un primario obiettivo: tenere accesissima nella popolazione l’attenzione sul virus e quindi ottenere massima adesione alle misure di contenimento. Il conflitto è voluto per tenere il pubblico concentrato.
Esiste un terzo scenario, che è forse il più realistico: include un miscuglio dei primi due (sinergia governo/media, indipendenza govern0/media), sommato all’improvvisazione giorno per giorno sia del governo che dei media. Stiamo esaminando fenomeni complessi, ai quali partecipano una pluralità di voci e di poteri: non si può ridurre a pochi tratti la descrizione del quadro socio-politico-mediatico complessivo. Esso è composto quindi da tentativi del governo di indirizzare pezzi dell’informazione, da tentativi dell’informazione di svincolarsi da indirizzi suggeriti dal governo, da fasi di azione concordata, da altre di corsa separata. Ma ciò che conta, a nostro avviso, è che certamente vi è stato un conflitto psico-socio-culturale tra italiani, che sono riusciti a dividersi ideologicamente anche in occasione di una vicenda tutt’altro che ideologica, la pandemia, e che questo conflitto è stato creato e poi alimentato dallo stile comunicativo del governo e dall’intensissimo martellamento dei media. Se vi è stata o meno una precisa volontà di creare questo scontro civile è molto difficile per noi stabilirlo. Se, inoltre, lo scontro civile sia stato un “male” o meno ai fini della pandemia stessa è al momento da parte nostra altrettanto indefinibile, ma di certo ha acceso tensioni e forse inutili contrapposizioni ideologiche tra gli italiani.